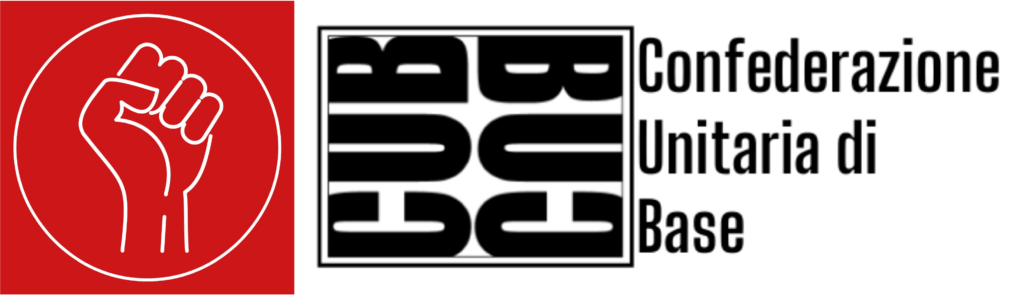I dazi: qualche spunto di riflessione fuori dal coro |
|---|
| Qual è il significato strategico dei pesanti dazi imposti dagli Usa alle importazioni di tanti Paesi molti dei quali alleati politici e militari? |
|---|
E questi passaggi trasformano gli Usa da paladini della globalizzazione ad alfieri del protezionismo? Il ruolo egemone degli Stati nazionali sta tornando in auge? E le sette grandi multinazionali (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Saudi Aramco, Facebook, Berkshire Hathaway, Visa) aventi ciascuna giri di affari superiori ai Pil di interi Paesi, rimarranno spettatrici passive davanti a ulteriori chiusure in negativo delle Borse?
A cura di Emiliano Gentili e Federico Giusti
Dalla fine della Seconda guerra mondiale al 2018 i dazi erano scesi dal 15/20% all’1%, per arrivare oggi invece alla media del 28-29% (una delle più alte raggiunte dalla metà dell’Ottocento ai nostri giorni). All’indomani della loro entrata in vigore le Borse hanno registrato grosse perdite (oltre 400 milioni di euro in un paio di giorni1) ma il vicepresidente Usa ha confermato la linea, dichiarando i dazi una misura «necessaria» per raddrizzare gli squilibri commerciali e precisando che «ci vorrà del tempo per vedere i loro effetti», e che quindi occorre aspettare e non cospargersi il capo di cenere. La stessa posizione attendista assunta, al momento, dal Governo Meloni e dalla stampa che lo sostiene (per ora la notizia più rilevante è che i Vicepresidenti del Consiglio e i Ministri dell’economia, delle Imprese, dell’Agricoltura e per gli Affari Europei saranno convocati dal Governo tra lunedì 7 e martedì 8 aprile, con lo scopo di assegnare loro l’incarico di produrre uno studio sull’impatto dei dazi sui rispettivi settori economici di riferimento).
- · Trump mira a riportare svariate produzioni negli Usa e con i dazi intenderebbe ripianare in buona parte il deficit federale che, tuttavia, si aggira attorno ai 1.800 miliardi, circa tre volte tanto la cifra ricavata dall’applicazione dei dazi. Il rifinanziamento del taglio delle tasse avvenuto nell’ultimo mandato presidenziale repubblicano (anno 2017) pesa per circa 450 miliardi di euro. Fatti due conti, a Trump mancherebbe ancora oltre un bilione (1.000 miliardi) se vuole cancellare il deficit federale. A questo punto, anche per ottenerne soltanto una semplice riduzione bisognerà abbattere drasticamente la spesa federale e il welfare;
- · conviene leggere un po’ di stampa straniera e statunitense per capire gli obiettivi della prossima Legge di Bilancio Usa, che presenta poderosi tagli fiscali da qui ai prossimi dieci anni, tagli a tutte le agenzie federali, un aumento del limite del debito nazionale di 4 trilioni di dollari e un aumento fattivo dello stesso debito dai 35,46 trilioni (1° ottobre 2024) ai 55,57 trilioni di Dollari (entro il 30 settembre 2034);
- · da autorevoli fonti statunitensi apprendiamo ad esempio dell’impossibilità della Cina di eguagliare i dazi Usa, pur avendo acquistato quasi 144 miliardi di Dollari di beni statunitensi nell’anno 2024. Coerentemente con la propria traiettoria di sviluppo economico – che tradizionalmente premia i settori economici più profittevoli e ne trascura altri, al fine di reggere il confronto sul mercato globale – la Cina potrebbe effettuare interventi specifici più pesanti, rafforzando il controllo delle esportazioni di metalli e terre rare necessari per realizzare i semiconduttori (e i prodotti tecnologici in generale) attuando la sospensione delle licenze di esportazione per sedici aziende statunitensi e aggiungendo altre undici società hi-tech a un «elenco di entità inaffidabili»3.
- · stando ai documenti ufficiali, «nel 2023 il totale degli scambi bilaterali di merci [con gli Usa] ha raggiunto gli 851 miliardi di euro. L’UE ha esportato 503 miliardi di euro di merci verso il mercato statunitense mentre ha importato 347 miliardi di euro; ciò ha comportato un avanzo commerciale di merci di 157 miliardi di euro per l’UE»4;
- · quanto a beni e servizi, l’Ue presenta un certo disavanzo commerciale con gli Stati Uniti, nonostante le “sparate” di Trump su un presunto furto perpetrato dall’Europa ai danni degli Stati Uniti tramite l’applicazione dell’Iva alle merci d’importazione. I beni prodotti nell’Ue pagano esattamente la stessa Iva di un qualsiasi altro prodotto importato, dacché l’imposta si applica sia ai beni nazionali che a quelli importati e, difatti, «Per motivi tecnici, non esiste un dato “assoluto” per le tariffe medie sul (segue)
- · dato il ruolo svolto dal personalismo di Trump, in questo momento, non è forse un caso che sia i dazi europei che quelli cinesi colpiscano anche alcuni settori-chiave per il consenso elettorale repubblicano. Nello specifico la Rust Belt (cuore industriale americano, attaccato dall’Ue) e le Great Plains (cuore agricolo, colpito dalla Cina)6. Per converso sarebbe utile, paradossalmente, uno studio accurato per comprendere quali siano i settori fino ad oggi salvaguardati.
5 Ibidem
6 Cfr. G. OTTAVIANO, I paradossi del protezionismo Trumpiano, «laVoce.info», 1° Aprile 2025.
- · Trump, Musk e gli altri tecnovassalli [Video]