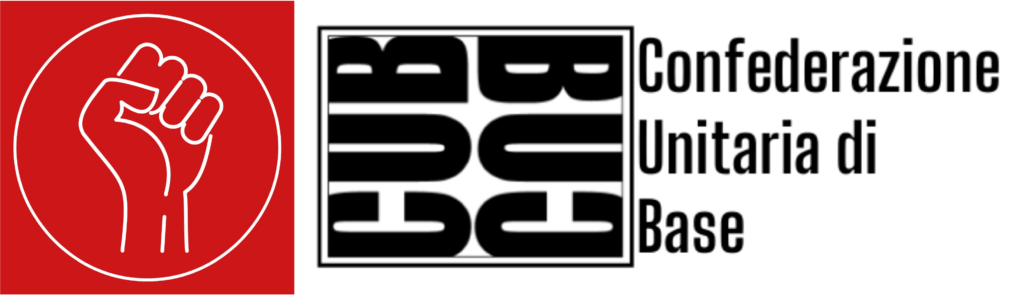USCITO IL RAPPORTO CENSIS 2025
I LAVORATORI FANNO POCO E NON SI INTERESSANO DELLE IMPRESE. CHISSÀ COME MAI…
(A cura di F. Giusti, S. Macera, E. Gentili)
Il nodo della produttività
«Se si sposta l’analisi al livello macro, l’Italia nel confronto con i maggiori paesi europei e con l’Unione europea nel suo complesso presenta negli ultimi anni una variazione negativa della produttività del lavoro, risultato questo di una crescita delle ore lavorate a fronte di un valore aggiunto incrementato non con la stessa intensità delle ore lavorate»[1].
Nel Rapporto Censis 2025 si conferma, dunque, quanto scritto negli ultimi mesi intorno ai temi della bassa produttività e dell’assenza di democrazia nell’organizzazione aziendale. In sostanza non si punta al reale coinvolgimento dei lavoratori nei processi produttivi ma, piuttosto, alla loro cooptazione a fini di mero controllo. Questa situazione contribuisce a generare disaffezione verso l’attività professionale, che a volte sfocia nell’assenteismo. L’evidente e strutturale ritardo italiano al cospetto degli altri Paesi europei non viene compensato neanche da qualche timido segnale di ripresa: negli ultimi cinque anni la produttività del sistema imprenditoriale nostrano è rimasta, in sostanza, ferma.
Le analisi risultano ancora più impietose laddove si sintetizzano le performance sul medio periodo: «Se si eccettua la Francia a partire dal 2019, l’Italia riporta la peggiore performance della produttività del lavoro, sia nel confronto con i dati dell’intera Unione europea, sia nei riguardi dei principali partner come la Germania e la Spagna. Nel lungo periodo, così come nel breve, l’Italia sembra caratterizzarsi per una bassa efficienza ed efficacia di sistema. I fattori e le cause alla base di quella che viene spesso chiamata la ‘malattia’ italiana e che vanno a condizionare sia gli esiti in termini di produzione e valore prodotto, sia gli assetti in termini di organizzazione del lavoro e dei fattori produttivi, sono riconducibili, da un lato, a vincoli di carattere generale e che vanno a collocarsi nell’area delle funzioni affidate agli apparati pubblici che dovrebbero facilitare l’attività di impresa e la capacità di adattamento dei sistemi produttivi, mentre spesso si pongono come ostacoli per le organizzazioni (fisco, giustizia, controlli). D’altro canto, riguardano anche la dotazione e la qualità di infrastrutture materiali e immateriali che supportano l’attività produttiva e gli scambi all’interno e all’esterno del Paese»[2].
È significativo che venga evocata la riduzione dei controlli e di una burocrazia (fiscale e giurisprudenziale) farraginosa e stratificata com’è quella italiana. Nel farlo, tuttavia, non viene detto che gli ostacoli legislativi all’iniziativa imprenditoriale sono anche e soprattutto il frutto di decenni di mediazione, da parte del legislatore, tra gli interessi di una grande imprenditoria in difficoltà cronica e un coacervo numerosissimo di piccole e medie imprese aventi capitali ridotti, che campa proprio sulla deregolamentazione del lavoro e su una grande varietà di esoneri, agevolazioni e permessi. Ma questa situazione disordinata genera a sua volta, come necessario contrappeso, una legislazione prescrittiva che pone dei limiti alle imprese e che alla fine risulta, per forza di cose, altrettanto composita e confusionaria.
Il coinvolgimento dei lavoratori
Con tutta evidenza, tra i motivi di preoccupazione espressi nel Rapporto, viene annoverato anche lo scarso coinvolgimento dei lavoratori. Ciò induce a riflettere sull’inadeguatezza delle attuali regole in materia di rappresentanza sindacale, visto che tra enti bilaterali, fondi previdenziali integrativi e assicurazioni sanitarie non mancherebbero le occasioni di incontro e per costruire una comune iniziativa tra la parte datoriale e i sindacati “maggiormente rappresentativi”. In linea di massima, gli strumenti della concertazione sono stati utili per costruire un consenso diffuso e forzato verso i sindacati firmatari di contratto, soprattutto tramite il ricatto della rappresentatività. Sotto altri aspetti, poi, la concertazione è anche stata il frutto di una mediazione tra parte datoriale, governo e sindacato, quale gentile concessione da parte del sindacato che ha optato per mettere in pratica un’opera di mediazione, garantendosi un ruolo ma rinunciando, allo stesso tempo, a ogni forma di conflittualità.
Se proviamo a riflettere sullo stato attuale della concertazione, si comprende che a decretarne la fine non è stato il sindacato ma il Governo, assieme alle parti datoriali. L’arrivo al potere della destra ha spaccato il sindacato concertativo: alla scontata azione filogovernativa dell’Ugl, si è aggiunta quella della CISL e di buona parte della galassia autonoma. Ciò consente all’esecutivo di avversare con decisione il ruolo egemonico della CGIL.
Non è un caso che fra le tante proposte di iniziativa popolare presentate proprio una sia stata attenzionata dal Governo, la proposta cislina sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese, che incarnava i desiderata della destra e di buona parte dell’imprenditoria nazionale. Sull’argomento abbiamo prodotto uno studio[3], del quale consigliamo la lettura per approfondire l’analisi e la conoscenza dell’intera vicenda.
In relazione al Rapporto Censis, però, la domanda da porsi è se la legge sulla partecipazione dei lavoratori potrà rispondere positivamente al forte bisogno di coinvolgere la forza lavoro nella gestione delle imprese. Ebbene, a nostro parere il coinvolgimento di singoli rappresentanti della forza lavoro (anche uno solo) negli organismi direttivi non potrà in alcun modo influenzare la democrazia sui posti di lavoro, rischiando per converso di trasformarsi in un ulteriore vincolo di potere ai danni dei dipendenti. Del resto, secondo la legge, sarebbero gli stessi rappresentanti dei lavoratori a essere sottoposti a vincoli normativi (spesso di carattere disciplinare) e finanziari.
Del resto, sul portale “liberal” degli economisti de Lavoce.info leggiamo: «Le agevolazioni fiscali che la legge approvata riconosce ai lavoratori rimangono, invece, le stesse di cui possono già beneficiare, con qualche variazione di importo. Il lavoratore che riceve una quota degli utili d’impresa può scegliere se assoggettare quel reddito alla tassazione ordinaria oppure all’aliquota del 5 per cento sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Quest’opzione può essere esercitata fin dall’entrata in vigore della legge 208/2015 (legge di bilancio per il 2016) che dava facoltà al lavoratore di applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento all’importo massimo di 3mila euro erogato come partecipazione agli utili d’impresa (art. 1, c. 182). Per il 2023 l’aliquota fu ridotta al 5 per cento (art. 1 c. 63 L 197/2022), confermata per il 2024 (art. 1, c. 18, L 213/2023). La legge di bilancio per il 2025 (art 1. c. 385, L 207/2024) ha mantenuto l’aliquota al 5 per cento per il triennio 2025-2027. Per questo tipo di agevolazione la sola novità introdotta dalla legge sulla partecipazione è l’innalzamento a 5mila euro dell’importo su cui si applica, ma solo per l’anno fiscale 2025. Il prossimo anno si torna, evidentemente, alle condizioni stabilite dalla legge 207/2024, come conferma il fatto che nella relazione tecnica al Ddl trasformato in legge, dopo il 2025 non si registra una perdita di gettito conseguente all’aumento dell’importo massimo a 5mila euro. È limitata al 2025 anche l’altra agevolazione accordata ai lavoratori: l’esenzione del 50 per cento su massimo 1.500 euro, come provento di dividendi delle azioni loro attribuite in sostituzione dei premi di risultato»[4].
Ragionando in termini capitalistici, è chiaro che il coinvolgimento della forza lavoro non fosse indirizzato e teorizzato in direzione di una reale co-gestione dei processi organizzativi e innovativi. Piuttosto l’obiettivo era di stimolare l’entusiastica partecipazione dei dipendenti ai destini e al lavoro dell’impresa. Dunque, quanto indicato nel rapporto Censis si riduce alla vecchia e classica idea che il capitalismo, per funzionare, abbia bisogno di un consenso diffuso e di una partecipazione attiva da parte della popolazione lavoratrice.
Proseguendo nella lettura, il Rapporto conferma le disparità di trattamento tra giovani e anziani, con i primi che si sentono di fatto esclusi. Invero, lo scarso coinvolgimento cresce anche con l’età e quindi possiamo ipotizzare che il problema sia trasversale alle generazioni, sia pur con differenti intrecci di cause e motivazioni (per alcuni i bassi salari, per altri i mancati riconoscimenti dell’anzianità e dell’esperienza, ecc.). E alla fine, in effetti, il Rapporto parla delle “3 D” che sintetizzano il sentire comune degli occupati dipendenti: Disimpegno, Disallineamento e Disincanto. Sul banco degli imputati sono posti anche la scarsa formazione e l’inadeguatezza delle competenze, specie per i giovani. Il che porta a riflettere sull’intero sistema formativo e sulla sua inefficienza, nonché sul conseguente fenomeno dei titoli di studio disallineati rispetto al lavoro realmente svolto. Leggiamo testualmente «Solo il 27,2% degli occupati dipendenti ritiene le proprie competenze perfettamente allineate alle esigenze lavorative (tab. 4). Percezione che aumenta con l’età: i giovani tra i 18 e i 34 anni mostrano il livello più basso (20,2%), mentre tra gli over 55 si raggiunge il 30,2%»[5].
Nella nostra lettura, tale disallineamento deriva direttamente dall’incapacità del ceto imprenditoriale italiano di posizionarsi nelle attività imprenditoriali che fanno uso di lavoro specializzato e che sono maggiormente redditizie. Una lettura confermata, del resto, dalla riforma dei tecnico-professionali e degli ITS Academy promulgata dal Governo Meloni e su cui pure, a suo tempo, abbiamo prodotto un articolo giornalistico[6].
La sociologia del Censis
Nell’epoca attuale sono inevitabili la “crisi del lavoro” e la difficoltà a mantenere del tempo libero. Nel Rapporto è scritto testualmente: «Una parte significativa degli occupati dipendenti ritiene che il lavoro abbia perso centralità nella propria vita o non sia mai stato considerato prioritario (47,8%, tab. 5). Le differenze generazionali sono particolarmente marcate. Tra i giovani dai 18 e i 34 anni, il 53,8% concorda con questa affermazione, in linea con il 54,4% della fascia 35-44 anni. Tra i 45 e i 54 anni la percentuale scende al 48,1%, fino a ridursi ulteriormente al 33,7% per gli over 55, praticamente 20 punti percentuali in meno rispetto ai lavoratori junior»[7]. Il lavoro ha perso non solo di appeal ma di centralità. E non perché si sia diffuso il “rifiuto del lavoro” e la speranza di vivere in qualche località di mare tra sussidi e ammortizzatori sociali…
Osservando le cose da un punto di vista sociologico, si potrebbe piuttosto affermare che in Italia sia stata progressivamente costruita una cultura mirante a squalificare il lavoro salariato, a ostacolare l’idea che si possa concretamente migliorare la propria condizione salariale e di vita attraverso il lavoro. Un’idea che all’epoca del “boom economico” degli anni ’60 era, invece, perfettamente compatibile col nostro quadro di sviluppo. Diverse analisi sociologiche[8], del resto, hanno confermato come negli ultimi decenni l’identità da lavoro (il sentirsi “operaio”, “impiegato”, “artigiano”, in base a ciò che si fa) abbia perso terreno in favore di altre declinazioni culturali (essere vegan, hipster, ecc.).
A conclusione del discorso andrebbe considerato un ultimo aspetto: la disaffezione al lavoro come deresponsabilizzazione individuale dovuta alla disgregazione, all’atomizzazione sociale. Disgregazione che è anche il portato del progressivo disimpegno pubblico in materia di welfare, socialità, miglioramento della qualità della vita, riqualificazione dei quartieri popolari.
RAPPORTO ISTAT SULLA POVERTA’ NELL’ANNO 2024
IPOTECA NEGATIVA SUL FUTURO DELLE GIOVANI GENERAZIONI
Il rapporto Istat sulla povertà nell’anno 2024 appena pubblicato ( https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/La-poverta-in-italia-_-Anno-2024.pdf) parla di 2,2 milioni di famiglie in condizione di povertà assoluta ossia quasi 5,8 milioni di persone, dati in aumento rispetto al 2023. Quando le statistiche vengono pubblicate la reazione immediata è quella di leggere acriticamente i numeri e per questo il rischio è di una parziale interpretazione della realtà. Un’analisi seria non deve essere piegata alla mera giustificazione delle politiche governative, vale con il centro destra come con il centro sinistra. Ad esempio la povertà assoluta riguarda famiglie in prevalenza composte da stranieri, le famiglie più numerose che vivono in pochi metri quadrati e in prospettiva con livelli di istruzione più bassi. E quindi dovremmo prendere in esame non solo le politiche migratorie ma una realtà lavorativa di sfruttamento e di salari diversificati dentro situazioni di elevata ricattabilità (perdere lavoro, anche il meno pagato, significa perdere il diritto di soggiorno).
La fotografia della realtà per quanto impietosa deve essere oggettiva e credibile, poi in un secondo momento arriveranno ulteriori considerazioni, ebbene salta agli occhi la differenza tra famiglie autoctone e quelle immigrate con queste ultime in condizioni decisamente più disagiate.
Se poi guardiamo alla povertà relativa i numeri diventano preoccupanti e vedono crescere la presenza delle famiglie italiane coinvolgendo una cifra ragguardevole di individui (quasi 8,8 milioni). Gli italiani vivono meglio degli immigrati ma subiscono un progressivo impoverimento che ritroviamo non solo tra le famiglie disoccupate, con lavori precari e part time ma anche laddove è presente un contratto full time e a tempo indeterminato a conferma che l’erosione del potere d’acquisto dei salari, e delle pensioni di cui ben poco si parla, sta producendo una massa crescente di poveri, di indebitati che stentano ad arrivare in fondo al mese.
Le famiglie in povertà assoluta sono più presenti nelle isole e nelle regioni meridionali e, si presti attenzione, anche in alcune province del centro nord (assai più di quanto accadesse solo 10 anni or sono) oggetto di feroci deindustrializzazioni la crisi si fa sentire producendo una crescente e diffusa miseria.
Ci interessa poco tracciare una mappa geografica della miseria (non a caso partiti del centro destra pensavano alle gabbie salariali con salari diversificati a seconda delle aree geografiche) tuttavia le zone dove minore è l’opportunità lavorativa e più debole l’offerta dei servizi pubblici sono quelle in maggiore sofferenza. Lasciamo all’Istat il compito di definire in termini percentuali l’intensità della povertà assoluta o l’incidenza di quella relativa, è difficile stabilire una cifra valida erga omnes e al di sotto della quale una famiglia cade automaticamente nella povertà, incide il costo della vita che cambia da regione a regione, il valore degli immobili, a quanto ammonta un affitto, alla tipologia dei lavori accessibili in base ai quali variano i contratti applicati. E poi se si abita in un’area metropolitana difficilmente si avrà un orto coltivato o un pollaio che qualche aiuto anche in termini economici possono garantire, anche se in caso di malattia ci si dovrà sobbarcare un viaggio della speranza verso gli ospedali del centro nord con relativi costi.
Negli ultimi anni la miseria si manifesta nelle aree metropolitane e nelle tradizionali province con minore reddito e tassi di disoccupazione elevati, dipende dalla composizione familiare perché un nucleo numeroso dovrà superare tanti ostacoli specie se con tre o più figli a carico. Se scopriamo anziani senza cure e con pochi soldi colpisce il deterioramento delle condizioni di vita di nuclei familiari con un’età media piuttosto bassa scoprendo, contrariamente a tanti luoghi comuni, la propensione al risparmio delle famiglie formate dai più giovani.
Fermiamoci qui con la nostra analisi e chi avesse voglia di approfondire abbiamo indicato la fonte Istat, proviamo invece a individuare alcune risposte e soluzioni alla miseria crescente:
Il titolo di studio ha ancora un peso effettivo, le famiglie povere sono anche quelle con titoli di studio bassi, costruire percorsi professionali ad hoc per chi ha abbandonato le scuole, arrivare a un diploma, portare studenti e studentesse a una laurea breve richiede impegni anche dallo Stato, investimenti adeguati nell’istruzione pubblica, politiche dell’abitare, borse di studio. Se non si aumentano allora le risorse destinate alla formazione e all’istruzione di ogni ordine e grado è inutile lamentarsi degli abbandoni scolastici e del basso numero di diplomati e laureati. Dovremmo poi pensare a percorsi formativi permanenti a prescindere dal lavoro svolto per contare su alternative reali in caso di licenziamenti.
La povertà è legata anche al caro affitti, da decenni manca un piano casa e un piano di edilizia popolare capace di dare risposte a un annoso problema.
La miseria attanaglia ormai anche quanti hanno un lavoro, l’erosione del potere d’acquisto è stata tanto forte da produrre in pochi anni uno tsunami sociale.
La scarsa mobilità sociale è una delle cause di questa condizione, avere poi posto fine al Reddito di cittadinanza non si è dimostrata una scelta oculata eppure il Governo è irremovibile su una decisione che, dati alla mano, ha solo accresciuto la miseria.
L’incidenza della povertà assoluta intanto nella fascia under 18 si fa sempre più preoccupante, di fronte a circa 1,3 milioni di bambini e ragazzi in condizioni di povertà scopriamo quanto siano ipocriti i richiami alla famiglia e all’infanzia, mai da 30 anni a oggi il deterioramento delle condizioni di vita ha colpito le fasce giovanili ipotecando negativamente il futuro delle giovani generazioni. Non si tratta di tutelare la famiglia come istituzione ma di potenziare il nostro welfare adeguandolo ai nuovi e reali bisogni.
Pensate che la prossima Manovra di Bilancio offra risposte e soluzione alla povertà crescente? No, stanzia solo risorse al Riarmo.
[1] Censis, Engagement e produttività. Rapporto di ricerca, Settembre 2025, p. 8.
[2] Ivi, p. 9.
[3] E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, https://cub.it/legge-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al-capitale-e-agli-utili-delle-imprese/
[4] R. Lungarella, F. Vella, Partecipazione dei lavoratori nelle imprese: tanto rumore per nulla?, https://lavoce.info/archives/107905/partecipazione-dei-lavoratori-nelle-imprese-tanto-rumore-per-nulla/
[5] Censis, op. cit., p. 15.
[6] E. Gentili, F. Giusti, La riforma degli istituti tecnico-professionali al suo primo banco di prova, https://giuliochinappi.com/2025/07/13/la-riforma-degli-istituti-tecnico-professionali-al-suo-primo-banco-di-prova/
[7] Censis, op. cit., p. 16.
[8] Cfr., ad esempio, N. Bertuzzi, C. Caciagli, L. Caruso: Popolo chi?. Roma: Futura Editrice, 2019.