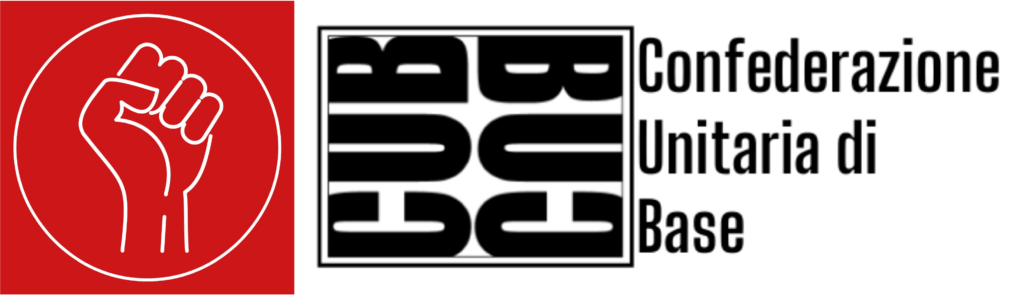SALARIO MINIMO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Negli ultimi anni in Europa stanno circolando due proposte politiche di grande impatto, che vengono considerate proficue sia per il lavoro dipendente che per l’impresa. Stiamo parlando della riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario e di produttività e del salario minimo orario. Sulla prima abbiamo già scritto[1], mentre ora proveremo a fare il punto sulla seconda – quella sul salario minimo –, sulla quale ultimamente sembra starsi concentrando il dibattito politico.
Il dibattito degli ultimi anni
Nel 2022 l’Unione Europea promulgò una Direttiva[2] – ossia una dichiarazione d’indirizzo che impone agli Stati nazionali di affrontare certe tematiche e perseguire determinati obiettivi a esse inerenti, lasciandoli però liberi di scegliere le modalità con cui farlo – che chiedeva il «miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo». Quindi: non direttamente il salario minimo, bensì l’accesso alla tutela che questo garantisce. Inoltre, «qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva [in uno Stato membro dell’Unione] sia inferiore a una soglia dell’80%», la Direttiva avrebbe imposto la costruzione di «un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime» e, quindi, la messa a punto di «un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva». In caso si fosse adottato un salario minimo legale (e solo in questo caso), poi, si sarebbe dovuto ricorrere a dei «valori di riferimento indicativi (…). A tal fine, si possono utilizzare valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60% del salario lordo mediano e il 50% del salario lordo medio». Considerando che il salario lordo medio italiano è attualmente di 15,57€/ora e, il netto, di 11,25€/ora[3], appare chiaro che la Direttiva Ue sia semplicemente un timido atto d’indirizzo volto a uniformare il mercato del lavoro comunitario soprattutto per quanto riguarda i Paesi economicamente meno sviluppati, non l’Italia. Persino la proposta di salario minimo del PD, infatti, è nettamente superiore ai parametri espressi nella Direttiva. Questa dunque era rivolta soprattutto a quei Paesi europei dove la contrattazione collettiva non esiste e che poi sono quelli che spesso si prestano a essere destinatari dei processi di esternalizzazione di alcuni servizi – Ungheria, Romania, alcuni paesi dell’ex-Yugoslavia –. La direttiva europea, dunque, doveva servire a placare la competizione intestina nel mercato europeo basata sulla sperequazione del costo del lavoro.
A prescindere da ciò, non tenere conto di una norma europea significa incorrere in procedimenti sanzionatori nei confronti del Paese inadempiente, ragion per cui il Governo dovette elaborare una strategia politica per fare fronte agli obblighi comunitari. Nel luglio 2023 Meloni diede mandato al Cnel di preparare una memoria sul lavoro povero e il salario minimo, che piacque anche ai sindacati confederali. Successivamente – in ottobre – venne avviata la cosiddetta “fase istruttoria tecnica sul lavoro povero e il salario minimo”, durante la quale uscirono fuori dei disaccordi con le parti sindacali (prima con la Cgil e, poco dopo, anche con la Uil)[4]. Proprio in ottobre, tra l’altro, arrivò una storica Sentenza della Corte di Cassazione[5] che, rifacendosi all’Articolo 36 della Costituzione, imponeva al legislatore il riconoscimento di un salario minimo de facto per tutelare un vigilante di un supermercato Carrefour che si era visto cambiare il contratto di lavoro e calare lo stipendio da un momento all’altro.
In tale contesto il Governo chiese al Cnel di fornire una misura della copertura contrattuale dei lavoratori italiani, per verificare che si fosse entro il limite minimo dell’80% fissato dall’Ue. In caso affermativo il Governo avrebbe potuto sostanzialmente ignorare la Direttiva e difatti la ministra del lavoro Calderone (FdI), alcuni mesi fa, ha detto che «non abbiamo bisogno di attuare la direttiva sul salario minimo, perché il livello della contrattazione collettiva nazionale in Italia è superiore all’80%»[6]. A essere sinceri siamo proprio al limite e, in ogni caso, nella percentuale dei “tutelati” vanno inclusi molti lavoratori vittime di contratti pirata fatti ad hoc[7] e firmati anche da una sola organizzazione sindacale, spesso confederale. Contratti di questo tipo sono relativamente comuni nelle situazioni di appalto e subappalto, dove minori sono i controlli e più bassi i salari e le tutele – spesso vale anche per gli appalti del pubblico, ad esempio quelli della sanità o delle pulizie. Purtroppo la questione dei contratti pirata (edulcorata dalle responsabilità dei confederali) è stata utilizzata mediaticamente come cavallo di troia da Governo e Confindustria che, uniti, mirano a eliminare la possibilità di una contrattazione di secondo livello di miglior favore, come quella che può scaturire da un più alto livello conflittuale – vedi le lotte del SiCobas nella logistica.
Questa prima fase del dibattito sul salario minimo è stata di fondamentale importanza perché con essa non solo si sono definiti meglio i contorni della questione, sia a livello politico che in relazione alle giurisprudenze italiana e, soprattutto, europea: si è anche consumato un passaggio politico importante che ha visto i sindacati confederali – tramite le consuete sponde partitiche nel Parlamento – barattare letteralmente un’opposizione più forte, magari anche di piazza, con la difesa della contrattazione collettiva svolta dai sindacati “maggiormente rappresentativi”. Secondo un comunicato del Cnel «L’intera rappresentanza datoriale, pur nelle sue diverse espressioni di settore, si è dimostrata compatta nel difendere il sistema della contrattazione collettiva, rispetto a soluzioni semplicistiche di un problema complesso, come quello del lavoro povero»[8].
Il vicepresidente del Cnel, espressione ufficiale di Confindustria all’interno dell’organismo, ha parlato esplicitamente di «un piano di azione nazionale, che potrebbe essere anche un utile contributo per consentire a Governo e Parlamento di riorientare, in termini di maggiore efficienza ed effettività, le risorse economiche a sostegno della contrattazione collettiva, dell’occupazione di qualità, del welfare aziendale e della produttività. Si tratta di ingenti risorse pubbliche che andrebbero indirizzate, in termini selettivi, verso i soli sistemi di contrattazione collettiva e bilateralità più consolidati»[9]. Probabilmente, quindi, in questa fase Confindustria spingeva per ottenere sgravi fiscali e incentivi per le imprese in cambio dei rinnovi dei Ccnl (orientati al welfare aziendale e alla produttività), nel tentativo di scaricare sulle finanze pubbliche parte degli oneri contrattuali.
La lettura complessiva del Cnel, infatti, è che il sistema imprenditoriale – e di conseguenza le condizioni di lavoro – sia troppo frammentato affinché si possa applicare una norma unificante come quella sul salario minimo. Probabilmente l’obiettivo è proprio quello di tutelare tutto quel sistema di appalti e subappalti che sfrutta il lavoro povero e, guarda caso, proprio adesso c’è il progetto per il Ponte sullo Stretto, che farà nascere centinaia di appalti diversi… Ad ogni modo la “giustificazione” ufficiale è che, quando si trovano attive nei settori che foraggiano il “lavoro povero”, per via della loro dimensione ridotta le imprese italiane non possiedono il capitale sufficiente per pagare di più i propri dipendenti riuscendo, al contempo, a rimanere competitive sul mercato… per cui bisogna che si adottino soluzioni ad hoc, gestendo «in modo articolato e mirato le diverse criticità del lavoro povero e dei salari minimi adeguati per tutti i lavoratori»[10]. Tali soluzioni possono essere individuate in contratti “farlocchi” stipulati tramite contrattazione con sindacati di comodo o nell’applicazione illegale di contratti inferiori a quelli previsti, col silenzio complice delle medesime organizzazioni sindacali e, spesso, anche del pubblico. Ciononostante, nel documento del Cnel si prova a scaricare su alcuni elementi del nostro welfare lavoristico la colpa dell’inattuabilità di un salario minimo, ossia sul fatto che «esistono in Italia voci retributive sui generis come la tredicesima, la quattordicesima, l’elemento di garanzia rispetto alla contrattazione decentrata di produttività», che renderebbero difficile alle imprese sopportare un onere salariale aggiuntivo. Ma del resto viviamo in un Paese dove il Governo si vanta della “crescita dell’occupazione” senza considerare lo “strano” fenomeno della concomitante riduzione delle ore lavorate… (guarda caso, sempre nello stesso documento – e, quindi, in tempi non sospetti – proprio il Cnel aveva dichiarato che una buona parte dell’incremento del differenziale retributivo occorso in quel periodo, ossia dell’aumento del gap esistente fra retribuzioni basse e alte, fosse «riconducibile alla diminuzione del numero delle settimane lavorate a tempo pieno». Come a dire: più occupati ma tutti con salari più bassi, cioè precari).
A proposito del Governo, si è presto visto che il suo vero intento non fosse quello di delegare la questione del “lavoro povero” alla contrattazione coi confederali, nel tentativo di annacquare i problemi e impedirne in tal modo una ricomposizione generale sul piano del dibattito pubblico – come stava avvenendo – o, peggio, su quello degli scioperi. Questo devono aver creduto le dirigenze di Cgil e Uil e del centro-sinistra… ma non certo quelle della Cisl, che infatti votava compatta tutti i documenti del Cnel. Quest’ultima nel frattempo si stava muovendo con una raccolta firme che avrebbe portato alla promulgazione di una legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa. Con questo provvedimento – scritto quasi “a quattro mani” col Governo, come si evince confrontando la Proposta di Legge originale con l’atto finale – il modello concertativo di relazioni industriali sarebbe stato semplicemente by-passato da un nuovo canale diretto fra rappresentanti filo-aziendali dei lavoratori (anche uno soltanto) e Consiglio d’Amministrazione. Ne abbiamo parlato recentemente, in occasione dell’uscita ufficiale della Legge[11]. Ora, si noti bene: la Proposta di Legge della Cisl venne presentata in Parlamento il giorno 27 Novembre 2023 e la raccolta firme era partita diversi mesi prima.
A questo punto il Partito Democratico – il partito di centro-sinistra con maggiori legami con la Cgil – cambiò strategia e cominciò a promulgare delle norme d’indirizzo sul salario minimo tramite i propri amministratori locali: Sindaci e Presidenti di Regione e anche semplici Assessori di Giunta di minoranza che hanno provato a far passare gli stessi contenuti tramite mozioni ad altri provvedimenti. Il primo atto importante venne adottato dal Comune di Firenze il 18 Marzo 2024, appena tre mesi e mezzo dopo l’approdo parlamentare della Proposta di Legge Cisl. Sempre nello stesso anno il Comune di Napoli e la Regione Puglia promulgarono disposizioni simili.
Il punto della situazione
La dialettica che negli scorsi anni si è sviluppata fra Cnel, Governo, imprese e sindacati confederali ha avuto un considerevole riflesso al livello del dibattito pubblico. Anche sindacati di base, organizzazioni politiche extra-parlamentari ed enti del terzo settore sono intervenuti, a volte con delle proprie proposte originali e strutturate su come istituire il salario minimo e sul valore che questo dovrebbe avere.
Mentre sulla questione della riduzione dell’orario lavorativo il Partito Democratico si era mosso congiuntamente a M5S e AVS – con la sponda della Cgil –, sulla tematica del salario minimo ha scelto un ruolo di maggior protagonismo, facendosi diretto portatore di una proposta di 9€/ora non indicizzati all’inflazione. Gli atti d’indirizzo, i protocolli d’intesa e le vere e proprie leggi regionali approvate dalle giunte PD hanno individuato nei 9€ un limite minimo per la retribuzione dei lavoratori dipendenti dell’istituzione locale e dei relativi appalti e subappalti.
Queste disposizioni differiscono nel modo con cui viene considerato tale limite: il Comune di Genova ad esempio si è mostrato molto più tiepido di quello di Firenze, che lo ha assunto in maniera più seria. In entrambi i casi però – come negli altri che abbiamo analizzato –, il salario minimo non è realmente «inderogabile», come invece vorrebbero i testi delle disposizioni. Il primo problema consiste nel fatto che, mentre per i lavoratori direttamente dipendenti dall’ente locale l’istituzione può teoricamente impegnare sé stessa a rispettare in maniera inderogabile il salario di 9€ (il che, per quanto non rappresenti una piena garanzia, può giustamente dare adito a speranze di un miglioramento delle retribuzioni), per i dipendenti in appalto e subappalto servono dei Protocolli d’intesa – fondamentalmente stipulati fra gli organi prefettizi, le istituzioni, le organizzazioni datoriali e i sindacati confederali – che impegnino i firmatari, senza poterli giuridicamente vincolare, al rispetto del suddetto salario minimo nei contratti stipulati in futuro. In alcuni casi, quando non si si sia concepito il Protocollo come un atto puramente simbolico, è stato stipulato anche un Protocollo sugli appalti per conferire maggiore importanza al criterio dei 9€, in un contesto di gara dove comunque la vantaggiosità economica dell’offerta rimane un aspetto fondamentale, spesso determinante per individuare l’azienda vincitrice: «Si lascia all’operatore economico che parteciperà alla gara di accettare o meno, liberamente, tale trattamento economico minimo [il salario minimo]»[12]. È possibile che sia preferito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a quello del massimo ribasso (rapporto qualità/prezzo versus il semplice prezzo più basso) e che il punteggio economico sia subordinato al cosiddetto “punteggio tecnico”, che deriva dal progetto aziendale, dalle competenze possedute, ecc. Tuttavia, non esiste la possibilità di imporre di non presentare un’offerta economica che preveda un salario inferiore ai 9€/ora, in quanto la disciplina degli appalti è sottoposta al D. Lgs. 36/2023 e la materia è di competenza del Governo nazionale. L’effettiva efficacia di un atto d’indirizzo sul salario minimo stipulato da un ente locale, per conseguenza, dipende dal settore economico considerato e, più in generale, dall’ecosistema economico del territorio. Di conseguenza questi atti d’indirizzo hanno il valore di “correttivi” (o “distorsivi”, a seconda del punto di vista) della concorrenza fra aziende, in quanto possono esercitare un’influenza.
Il secondo problema di queste pseudo-norme sul salario minimo è che non si tratta di disposizioni che mirano a risolvere in toto la questione degli appalti che sfruttano “lavoro povero”, limitandosi all’aspetto della retribuzione oraria. Nulla viene detto, o fatto, a proposito dell’abuso di contratti precari, dei numerosi appalti in cui i lavoratori vengono considerati “beni o servizi” anziché “manodopera” (con conseguente decurtazione dei livelli salariali e delle tutele), del proliferare dei subappalti, delle ingenti risorse pubbliche assorbite da ditte appaltatrici che, indipendentemente da ciò, continuano a pagare poco i propri dipendenti, dell’applicazione di Ccnl pirata, spesso scaduti, con l’assenso dell’amministrazione locale.
Il terzo e ultimo problema – per quanto ne sappiano gli scriventi – consiste nel fatto che questi atti d’indirizzo sul salario minimo vengono impugnati dal Governo nazionale, che ritiene di poter essere l’unico a legiferare sulle retribuzioni degli appalti. Eppure – ci si domanderà –, se la norma non è prescrittiva e quindi non impone per obbligo di legge l’applicazione del minimo di 9€, perché viene impugnata? Probabilmente se il PD non avesse inteso farsi pubblicità con queste pseudo-leggi inconcludenti e avesse semplicemente modificato i criteri di bando, senza pretendere di aver introdotto un salario minimo – visto che non è vero –, il Governo non avrebbe impugnato alcunché.
Conclusioni
Le finte leggi del PD non tutelano realmente i lavoratori esternalizzati degli appalti pubblici, se non in maniera marginale. Per migliorare le condizioni di lavoro servirebbe una norma forte, che possa stabilire ad esempio che in tutti gli appalti pubblici si applichi un contratto nazionale che non preveda servizi esternalizzati o, in caso contrario, che imponga alle ditte appaltatrici un pagamento non inferiore a quello del contratto summenzionato. In questo modo si stabilirebbe che un lavoratore esternalizzato non debba percepire nemmeno un € in meno rispetto ai contratti applicati ai dipendenti diretti della stazione appaltante. Inoltre verrebbe risolto anche il gap tra contratti pubblici e degli enti locali, che ammonta ormai a circa 200€.
Infine, bisognerebbe ridurre il numero di contratti. Alcuni di questi – come il contratto delle cooperative sociali – sono stati creati per favorire l’esternalizzazione, nonostante al tempo si dichiarasse di stare semplicemente fornendo una sorta di “contratto d’inserimento” nel mondo lavorativo ai più svantaggiati. E infatti, si vede! A lavorare con questi contratti ci vanno, spesso e volentieri, dei laureati. E allora, forse è il momento di prendere atto che tutte le tipologie precarie di contratto nate negli ultimi 35/40 anni sono servite ad abbassare il costo del lavoro, a ridurre il potere d’acquisto e quello di contrattazione. Ne è prova recente il nuovo contratto del settore cargo aeroportuale, firmato da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. In esso si prevedono la maggiorazione domenicale di un misero 10%, per una categoria che normalmente lavora 2/3 domeniche al mese, e una risibile somma risarcitoria per le problematiche legate all’utilizzo dei moltissimi dispositivi di protezione[13] (i lavoratori avevano fatto ricorso perché costretti a lavarseli da soli), dell’ammontare di 16,80€ al mese per gli operai e di ben 6,60€ per gli impiegati, per giunta in cambio della firma su un documento di conciliazione individuale che risolva i ricorsi in fase di procedura legale. In tutto ciò, apprendiamo da un comunicato sindacale[14] che prima di siglare il contratto le organizzazioni firmatarie non si sono nemmeno consultate coi lavoratori!
Note:
[1] E. Gentili, F. Giusti: Riduzione dell’orario di lavoro: in che direzione si sta procedendo?, https://cub.it/riduzione-dellorario-di-lavoro-in-che-direzione-si-sta-procedendo/
[2] Direttiva UE 2022/2041 del 19 Ottobre 2022, preceduta dall’atto COM(2020)68 (proposta di Direttiva).
[3] Nel 2019 i dati Istat stimavano il salario lordo medio in 14,20€/ora.
[4] Tali dissensi sono sostanzialmente nati con la promulgazione di un importante documento da parte del Cnel, intitolato Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia e approvato, con soli 15 voti contrari, dall’Assemblea del 12 Ottobre 2023.
[5] Sentenza n. 27711 della Corte di Cassazione.
[6] A. Giuzio, No al salario minimo. Il governo impugna la legge pugliese, «il Manifesto», 1° Febbraio 2025.
[7] Secondo il Cnel i contratti “pirata” sono poco più di 350 in totale, interessando solo lo 0,4% della forza-lavoro. Nutriamo dubbi su questo dato, in quanto potrebbe esservi una discreta quota di “sommerso”.
[8] Cnel, Comunicato stampa: Salario minimo, approvato primo documento Cnel – i punti salienti, 4 Ottobre 2023.
[9] Dichiarazioni di Botta contenute in “Cnel, op. cit.”.
[10] Cnel, op. cit.
[11] E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Partecipazione lavoratori agli utili: una critica analitica, https://diogenenotizie.com/partecipazione-lavoratori-agli-utili-una-critica-analitica/
[12] Comune di Firenze, Vademecum per gli enti locali, p. 2.
[13] Stando all’accordo, sono riconosciuti come Dpi «Scarpe antinfortunistica, guanti, gilet alta visibilità, otoprotettori, completo anti-pioggia, giaccone invernale alta visibilità, ginocchiere», mentre restano esclusi gli indumenti da lavoro ordinari, come le uniformi. Cfr. Verbale di accordo del 6 Agosto 2025, stipulato fra Gruppo Bac, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, p. 1.
[14] Cub-Trasporti, Comunicato stampa: Cargo aeroportuale: accordi su Dpi e domeniche, un’altra firma contro i lavoratori, 7 Agosto 2025.