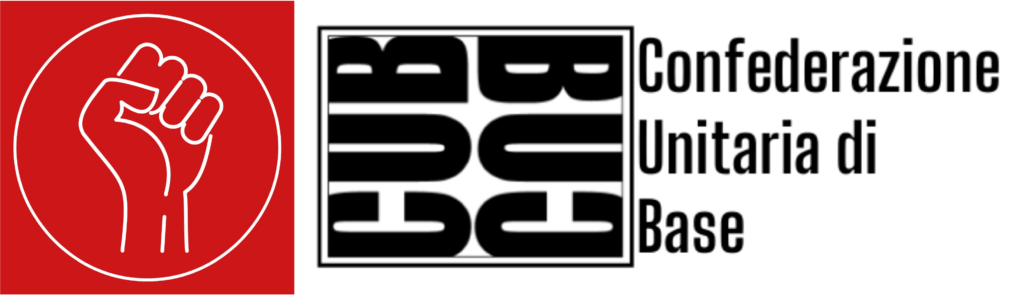Note sulla Legge sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva
(A cura di E. Gentili e F. Giusti)
Il 23 Settembre scorso è terminato l’iter parlamentare del Disegno di Legge 957 sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva. Originariamente la proposta era partita dall’opposizione di centro-sinistra ma successivamente il Governo ha fatto propria l’iniziativa, riscrivendone il testo; la nuova versione ha nei fatti mutato i caratteri originali della norma, ragion per cui ai deputati che l’avevano sostenuta non è rimasta altra strada se non il ritiro, in blocco, delle firme. Proviamo allora a entrare nel merito della questione
L’articolo 1 del testo di Legge delega le istituzioni a stabilire dei criteri per la definizione della retribuzione minima. Rispetto alla versione del centro-sinistra scompaiono sia la soglia d’importo dei 9 € lordi all’ora (ex-art. 2) che la commissione per l’aggiornamento del valore del salario minimo (ex-art. 5). Inoltre, la definizione e l’eventuale aggiornamento del trattamento minimo in base all’inflazione non sarebbero basati sui Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”, bensì sui contratti «maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti»[1]. Tale modifica potrebbe sembrare democratica ma in sostanza è funzionale ad applicare i contratti più sfavorevoli e vorremmo fare un solo esempio: in numerosi appalti si applica il Contratto nazionale multiservizi ma stando a questa norma non sarebbe ammissibile sostituirlo con un Federculture che, invece, meglio si addice ad alcune tipologie di lavori (ad esempio nel settore museale). Insomma, a prevalere è la consuetudine, dopo anni di accordi e soluzioni favorevoli solo alla parte datoriale. A nostro parere, inoltre, nelle intenzioni di Meloni vi è l’idea di marginalizzare i sindacati confederali nel tentativo di superare (o depotenziare) l’istituto della contrattazione in sé[2]. Del resto il Governo ha anche eliminato l’articolo sulla repressione delle condotte elusive degli imprenditori (ex-art. 6), che prevedeva l’intervento del Giudice del Lavoro sulla base di un ricorso sindacale, sostituendolo con l’intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[3]. Per concludere, secondo la nostra interpretazione l’utilizzo della categoria dei contratti maggiormente applicati mira anche a stabilire, col tempo, un modello contrattuale nel quale il secondo livello abbia il sopravvento sul primo. Navigano a vista, ma seguendo un disegno ben preciso: il potere datoriale deve essere rafforzato e qualsiasi intervento legislativo deve contenere il costo del lavoro.
E in tutto ciò, ai confederali resta poco: una frase in cui si delegano le istituzioni a «prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale». Dunque, anziché stabilire ad esempio delle clausole contrattuali a base territoriale per determinare una componente accessoria del salario che risponda a tali «esigenze diversificate»[4], si propone di assegnare tale compito al mercato rafforzando, ancora una volta, la contrattazione di secondo livello.
L’ultimo aspetto concernente l’articolo sulla retribuzione minima su cui vale la pena soffermarsi riguarda il citato contrasto del lavoro sottopagato «anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro». Considerando che più avanti viene detto che si dovrà «procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica», non è azzardato ipotizzare una forte spinta del Governo per sostituire il sistema delle cooperative con quello, più a marca francese, delle agenzie interinali. È evidente che una soluzione siffatta precarizzerebbe ulteriormente il lavoro (per quanto nelle cooperative la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro siano sì part-time ma a tempo indeterminato).
All’articolo 3, concernente le disposizioni finanziarie, viene concepita la possibilità che i decreti attuativi che verranno possano prevedere nuovi o maggiori oneri. Eppure, rispetto testo della proposta del centro-sinistra risulta eliminato il riferimento esplicito al beneficio da concedere «in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo» (ex-art. 7). L’istituto potrebbe tornare nei decreti attuativi ma nel caso così non fosse il fatto sarebbe interpretabile come un segnale che si prevedono adeguamenti degli importi inferiori ai 9 € lordi.
Infine un ultimo appunto. Com’è forse nello stile di questo Governo, la forma del testo di legge è relativamente poco definitoria e prescrittiva, sicuramente meno rispetto al DdL originario. Dal testo scompaiono molti riferimenti legislativi e molte definizioni e precisazioni aventi valore giuridico. Un esempio su tutti? La cancellazione di ogni richiamo testuale diretto al lavoro autonomo e al rapporto di collaborazione continuativa. Ciò potrebbe anche essere interpretato come un allentamento dei vincoli per gli estensori delle future leggi attuative di quella che, lo ripetiamo, è soltanto una legge-delega.
[1] Secondo Pietro Ichino, tuttavia, è «poco probabile che la disposizione possa superare il vaglio di costituzionalità». Cfr. P. Ichino, Retribuzioni: quanto c’è di buono nella legge delega, https://lavoce.info/archives/109009/retribuzioni-quanto-ce-di-buono-nella-legge-delega/.
[2] Cfr. E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, https://cub.it/legge-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al-capitale-e-agli-utili-delle-imprese/. Tale legge è richiamata all’art. 1, c. 2, lett. “i” del testo in esame. Si consideri, infine, che Il criterio dei Ccnl maggiormente applicati offre l’escamotage politico per bypassare l’istituto di una “soglia retributiva minima inderogabile”.
[3] Il Governo ritorna sul tema anche all’art. 2, c. 1, lett. “b”, ma in un’ottica diversa. A parte, si tenga presente che gli interventi del centro-sinistra avevano comportato che i costi di un ricorso al Giudice del Lavoro fossero addebitati al soccombente (ossia per lo più ai lavoratori).
[4] Cfr. E. Gentili, L’attacco degli imprenditori. Roma: Sensibili alle foglie, 2025, pp. 382-383.